Il mobilio della cucina era sobrio ed essenziale e consisteva di pochi
pezzi, in gran parte realizzati artigianalmente in legno e quindi senza
quei materiali e trattamenti che permettono alle nostre cucine di non
graffiarsi, di non macchiarsi, di mantenersi inalterate nel tempo senza
portare la memoria di tanti gesti quotidiani.
 I
mobili esposti in mostra sono tra i più diffusi nella cucina
di ieri anche se alcuni sono ricostruzioni da noi realizzate.
I
mobili esposti in mostra sono tra i più diffusi nella cucina
di ieri anche se alcuni sono ricostruzioni da noi realizzate.
Punto focale di questa cucina della memoria è il camino,
costruito con blocchi di arenaria: el camin de molera. Probabilmente
costruito con la "molera" estratta dalle cave sulla Bevera, tra
Briosco e Capriano, e lì direttamente scolpito.
Sul fondo, dietro al focolare, è stata murata una lastra, sempre
di arenaria (la preja del camin) per riparare il muro dalla violenza
del fuoco.
Il fuoco, el föch, era un elemento importante ed era cura
della donna di casa o de la regiura regolarlo e tenerlo sempre acceso.
A lato del camino, in una vecchia marnetta di legno,
abbiamo posto la materia prima per poter alimentare un buon fuoco: la
legna (da consumarsi con molta parsimonia), i fusti e i tutoli del granoturco
(i melgasc e i galuzzit o lüit) ed anche sterpaglie.
La legna, già tagliata, veniva sminuzzata accanto al camino,
su una pietra, con la roncola (riscîot) o con una piccola scure
(segürin). I fiammiferi (i sofranej) sono nell'apposito
contenitore.
Il fuoco era ravvivato soffiando dell'aria, con il mantice (bofett)
o con un tubo di ferro, sulla brace (brasca). Per muovere la
legna si usava la molla (möja) e l'attizzatoio (rampin).
La cenere (scender) o le braci venivano rimosse o spostate con
una paletta (el bernasc).
Una paletta ancor più piccola (bernascin) veniva impiegata
per mettere le braci nel ferro da stiro (supressa) o negli scaldini.
Tra questi abbiamo: el scaldin di pèe, in ferro, con una
griglia e un manico per poterlo spostare (le donne lo portavano anche
in chiesa, specialmente quelle che in inverno andavano a messæ
primæ). El scaldalecc era invece munito di un lungo
manico e si faceva passare ripetutamente sulle lenzuola. Tra le lenzuola
si lasciava anche el scaldin protetto da un telaio in legno chiamato
prêt.
Al centro del camino, dall'interno della cappa, penzola una catena,
la cadèna del camin, costruita con una serie di
ganci che permettevano di regolare la distanza del recipiente di cottura
dal fuoco o dalla brace. A questa è appeso il paiolo per la polenta
detto pairö o stégnâ perché,
essendo in rame, veniva accuratamente stagnato, per evitare avvelenamenti
prodotti dal verderame.
Per rimestare la polenta si usava el menau o menun, detto
anche canè la o bastun de la pulénta.
Alla catena si appendeva anche la padèla dove si cuocevano
minestre, stufati (stüâ) e risotti; nella calderéta
si bolliva el less.
Sui treppiedi (tripé) sono appoggiati il pentolino (calderin
del cafe) e una padella con manico (padelitt). Il caffè
o altri semi (orzo e i gandulit d'üga) venivano tostati
nei vari tostini (tustin), a tamburlano o a manovella, e macinati
nel masnin del cafe.
Nel camino si preparavano anche le castagne arrosto (büroj)
con la padella bucata.
La donna di casa aveva sempre a portata di mano il sale (la saa)
tenuto nel portasale accanto al camino il cui calore lo manteneva sempre
asciutto.
 Gli altri
utensili, anch'essi tenuti poco lontani: mestoli, schiumarole, palette,
forchettoni, colini, imbuto (taza, cazzüü, scümaröla,
paléta, furchetun, culin e pedriöö) erano appesi
alla mestoliera (lecardéra).
Gli altri
utensili, anch'essi tenuti poco lontani: mestoli, schiumarole, palette,
forchettoni, colini, imbuto (taza, cazzüü, scümaröla,
paléta, furchetun, culin e pedriöö) erano appesi
alla mestoliera (lecardéra).
Il padrone di casa, ul regiù, sulla mensola del camino,
accanto a bugia e portacandele, teneva gli unici suoi oggetti di vizio:
tabacchiera, toscani, o in tempi più vicini a noi, le sigarette:
Alfa e le famigerate Milit. Una scatola cilindrica posta sulla mensola
ci testimonia della presenza anche delle cigarettes che, in abbondanza
e con altre leccornie quali il cioccolato, uscivano dal Parco della
villa Reale quando nel 1945 vi erano accampati gli Alleati della 5a
Armata.
C'erano momenti nella giornata, o durante la notte, in cui il fuoco
del camino si spegneva; in questi casi si ricorreva, per continuare
a scaldarsi, al mattone refrattario, ul quadrel, che veniva scaldato
sul fuoco e manteneva a lungo il calore, tanto da poter essere usato
anche per scaldare le lenzuola. La bottiglia, o la boulle dell'acqua
calda (la diversa denominazione deriva soltanto dalla forma, verticale
od orizzontale) veniva invece riempita di acqua bollente, ed aveva la
medesima funzione del mattone.
 Di
fronte al camino si trovava lo sgabellino (cadreghin), usato
dai bambini e dalle nonne.
Di
fronte al camino si trovava lo sgabellino (cadreghin), usato
dai bambini e dalle nonne.
A fianco del camino, sotto la finestra troviamo la ghiacciaia, o giasirö.
Era un mobile, non molto diffuso, che serviva per conservare al fresco
i cibi. L'interno era suddiviso in due parti: una, impiegata per riporvi
i cibi da conservare e un'altra per ospitare i blocchi di ghiaccio.
La ghiacciaia era dotata di un rubinetto che permetteva di far defluire
l'acqua quando il ghiaccio scioglieva. Sopra la ghiacciaia abbiamo posto
una brentina di alluminio per riporre il latte appena munto con il misurino
(da mezzo litro) per distribuirlo e un fornelletto a petrolio (svea)
usato in caso d'emergenza.
La piattaia (piatera), un mobile appeso alla parete,
era costituito da assi orizzontali sulle quali venivano appoggiati i
piatti e altre suppellettili. Nella parte inferiore, munita di ganci,
si appendevano i recipienti più grandi (caldâr, sidei,
stagnaa). Si riconoscono stoviglie da tavola come piatti, vassoi
e zuppiere, stampi per dolci, barattoli in alluminio per caffé,
zucchero, caffettiere, macinini per il pepe, grattuggia a manovella
per il formaggio ed il pane secco, tortiere in alluminio (la basleta
che la regiura usava per mondare il riso o le lenticchie - i lenti
-).
Di particolare interesse i recipienti di legno (baslot) che venivano
usati per impastare la farina, l'acqua e il lievito.
La credenza (cardenza) poteva essere di varie dimensioni.
Veniva utilizzata per riporre stoviglie, tovaglie, strofinacci, e ingredienti
di cucina di facile conservazione come il lievito, i vari grassi, le
spezie. Non tutti i cibi venivano conservati nella credenza, anzi, la
maggior parte di essi si trovava nella dispensa che, a differenza delle
abitudini attuali, era collocata fuori dalla cucina, solitamente in
un angusto locale privo di finestre o con finestre molto piccole, posto
in una zona ombreggiata per poter meglio mantenere le vivande.
 Sulla
nostra credenza è appoggiata una scatola per il cucito contenente
lana, aghi per sferruzzare (scalfit) che venivano usati dalle
donne di casa per creare calze, scialli (scialet) e tutto ciò
che potesse servire per affrontare i rigidi inverni. Possiamo anche
vedere dei modelli per il punto croce che venivano usati per ricamare
i corredi delle figlie (ricamá la dóta). Una grande
importanza avevano anche aghi, filo (reff) ed il classico uovo
di legno per poter rammendare i vestiti che ovviamente dovevano durare
almeno quanto il proprietario. Nelle scatole da cucito venivano riposti
ogni genere di oggetti di recupero: bottoni (butón), pezze
per il rammendo, fibbie, ganci. Queste scatole rappresentavano, nei
giochi dei bambini, i forzieri in cui trovare luccicanti tesori.
Sulla
nostra credenza è appoggiata una scatola per il cucito contenente
lana, aghi per sferruzzare (scalfit) che venivano usati dalle
donne di casa per creare calze, scialli (scialet) e tutto ciò
che potesse servire per affrontare i rigidi inverni. Possiamo anche
vedere dei modelli per il punto croce che venivano usati per ricamare
i corredi delle figlie (ricamá la dóta). Una grande
importanza avevano anche aghi, filo (reff) ed il classico uovo
di legno per poter rammendare i vestiti che ovviamente dovevano durare
almeno quanto il proprietario. Nelle scatole da cucito venivano riposti
ogni genere di oggetti di recupero: bottoni (butón), pezze
per il rammendo, fibbie, ganci. Queste scatole rappresentavano, nei
giochi dei bambini, i forzieri in cui trovare luccicanti tesori.
La cucina era un importante punto di ritrovo per donne e bambini spesso
in preghiera per recitare il rosario (ul rusari) che scandiva
le attività quotidiane per la preparazione dei cibi. L'immancabile
corona (cúruna del rusari) era tenuta solitamente dalla
donna più anziana che veniva in questo modo esonerata da quei
lavori che per la vista debole o per gli acciacchi dell'età non
poteva più svolgere. Sulla credenza era quindi riposta la corona
con il libro delle preghiere (libar di orazion) per poter essere
sempre a disposizione.
Nei cassetti si trovavano le posate, i coltelli (i curtei) da
cucina, la mezzaluna, il tagliere e tutti quegli attrezzi di piccole
dimensioni che servivano al vivere quotidiano: cavatappi (cava büscion),
apriscatole, la rotella per i ravioli, lo stampo per i cappelletti,
lo stampo per le rosette. Di particolare interesse si può notare
una serie di fruste che testimoniano il passaggio da quelle più
classiche fino allo sbattiuova a manovella più vicino a noi.
Con il passare del tempo sul ripiano della credenza hanno preso posto
gli oggetti di uso più frequente: il borsellino con i soldi spicci,
la sveglia, le carte da gioco, la bilancia. Sotto le feste i bambini
ponevano anche i loro salvadanai nella speranza che un topolino ci mettesse
qualche soldo. Topi che erano di casa in cucina come si può vedere
dalle numerose trappole che sono poste sotto la credenza.
Dalla credenza i ritratti degli avi sorvegliavano austeri tutte le attività
quotidiane. Le cornici ospitavano anche le immaginette dei santi (santit)
a cui la famiglia era più devota.
 La
madia era un mobile usato nella preparazione del pane. Vi si stivavano
il lievito e la pasta del pane. Se usata come mobiletto coperto vi si
conservava il pane stesso, la farina, avanzi di cibo e sacchi di granaglie
varie che venivano prese con apposite palette. Sopra la madia abbiamo
posto dei setacci che servivano a passare la farina per eliminare eventuali
impurità. Due cestelli, uno dei quali (quello realizzato in filo
metallico) serviva per la raccolta delle verdure nell'orto e le uova
fresche dal pollaio.
La
madia era un mobile usato nella preparazione del pane. Vi si stivavano
il lievito e la pasta del pane. Se usata come mobiletto coperto vi si
conservava il pane stesso, la farina, avanzi di cibo e sacchi di granaglie
varie che venivano prese con apposite palette. Sopra la madia abbiamo
posto dei setacci che servivano a passare la farina per eliminare eventuali
impurità. Due cestelli, uno dei quali (quello realizzato in filo
metallico) serviva per la raccolta delle verdure nell'orto e le uova
fresche dal pollaio.
Di fianco alla porta spesso si trovava un gancio mobile (con movimento
"a bandiera") per reggere il secchio dell'acqua (sidela)
con un mestolo (cazzùù). L'acqua veniva prelevata
da uno dei pozzi o delle pompe posti nel cortile della cascina. Anche
nel cortile della nostra cascina si trova una pompa per l'acqua perfettamente
funzionante.
Altri oggetti comuni erano la zangola, usata per la preparazione del
burro. In questo caso ne abbiamo una a manovella e un'altra più
piccola di tipo più tradizionale.
Nella vita quotidiana di una massaia c'era il bucato. Di solito si andava
al lavatoio o al fiume, ma per le piccole cose si usava un catino (bagnin)
accompagnato da un piccolo asse. Nello stesso catino venivano lavati
piatti, stoviglie e ... bambini !
 La
moschirola era un armadietto con le pareti costituite da reticelle
a maglie molto sottili che impedevano agli insetti di entrare e nel
contempo permettevano al cibo di restare fresco e conservarsi più
a lungo. Vi si riponevano formaggi, salumi e cibi avanzati che non potevano
essere conservati al chiuso.
La
moschirola era un armadietto con le pareti costituite da reticelle
a maglie molto sottili che impedevano agli insetti di entrare e nel
contempo permettevano al cibo di restare fresco e conservarsi più
a lungo. Vi si riponevano formaggi, salumi e cibi avanzati che non potevano
essere conservati al chiuso.

La cassapanca era un mobile a forma di cassa usato come baule,
armadio e sedile.
La cucina veniva illuminata, oltre che dalla luce del sole (la giornata
iniziava all'alba e finiva al tramonto) anche dal fuoco del camino e
dal chiarore di lampade a petrolio e a candela.
Il quadro
raffigurante la Sacra Famiglia era immancabile in ogni cucina, visto
che la religiosità era allora non soltanto un fatto di costume,
ma un vero e proprio modus vivendi. Con la sua presenza, esso
custodiva gli abitanti della casa e vegliava sulla loro pace spirituale.
E quale miglior modo di vegliarla, se non quello di partecipare ai loro
momenti di ritrovo collettivo? E quale momento migliore per ritrovarsi,
se non quello del pranzo e della cena? Pranzo e cena che venivano consumati
dalla famiglia intera, una famiglia di stampo patriarcale, dove i componenti
andavano dai bambini ai bisnonni, ma che venivano accomunati dal riunirsi
intorno ad un tavolo.
Il tavolo (taôl) serviva sia per mangiare che come piano
per preparare i cibi. Il nostro tavolo č disseminato di utensili, di
piatti e contenitori: il tagliere per la polenta (âsa dela
polênta), con il suo tagliapolenta in legno, gli scodelloni
(baslott, baslö, o basla de lêgn); il tagliere comune
e il coltellaccio per il lardo (pestalard e cortêla del lard),
l'immancabile mattarello (canêla), nonchč i pestacarne
di vario tipo e modello (batiröla).
Ma con il passare degli anni, molti uomini abbandonarono il mestiere
di contadino, tanto rischioso, quanto faticoso, per dedicarsi a qualcosa
di più economicamente sicuro, qualcosa che dava la certezza di
poter avere un salario su cui contare alla fine di ogni mese, indipendentemente
dagli agenti meteorologici. Così, numerosi furono coloro che
trovarono lavoro nelle fabbriche, formando la classe operaia, destinata
ben presto a superare di gran lunga il numero di quelli che rimasero
affezionati all'agricoltura. Non sempre però gli operai potevano
tornare a casa per il pranzo. Sorse allora la necessità di portarsi
il cibo da casa visto che le mense aziendali sono "un'invenzione"
molto più recente. Ecco spiegato quindi l'uso della gavetta (schisceta),
dove venivano posti gli alimenti in modo da poter essere consumati dopo
parecchie ore, se non caldi, almeno appena tiepidi.
Nulla manca a questa cucina di ieri, a questo attimo di raccolta intorno
ad un camino, in un mondo lontano, in un'epoca ormai inesistente, se
non nella memoria di qualcuno, forse di tutti. Nulla manca se non le
voci, i rumori, la vita, le persone. Non abbiamo potuto ricreare queste
cose, perché stanno solo dentro di noi. Se vogliamo ritrovare
per intero questa atmosfera del passato, se vogliamo per un attimo calarci
in un mondo cosė distante da noi, proviamo soltanto a chiudere gli occhi
. . .


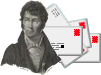 Museo
Civico "Carlo Verri"
Museo
Civico "Carlo Verri"