Le immagini potevano riferirsi alla sfera religiosa, con una ricca serie
di divinità e di loro attributi, sia ufficiali che delle religioni
tollerate (come quella isiaca o quelle orientali in genere), all'interno
di un sistema di propaganda e indottrinamento che poteva avere carattere
ufficiale. Frequenti sono i riferimenti al mito, con i personaggi più
popolari: Atteone, Leda con il cigno, Pan e i satiri, i Grilloi (nani
deformi), ecc..
Le immagini relative alla sfera religiosa ci propongono più una
dimensione di superstizione domestica che di culto ufficiale, per la quale
si aveva nelle case una ricca produzione di immagini in metallo o in altri
materiali.
Ufficiali dovevano essere invece le figurazioni che si riferivano alle
"opere del regime": edifici, porti, scene di trionfo ecc. Per
tali figurazioni, come per quelle che proponevano divinità o personificazioni,
i riferimenti ai tipi monetari appaiono continui. Le funzioni dei due
multipli (i più diffusi nel mondo antico) erano analoghe.
Assente invece sembra la propaganda imperiale diretta, con le immagini
dell'imperatore o dei suoi parenti. Il supporto evidentemente non era
caratterizzato da una forte sacralità, come la moneta. Appaiono
però frequenti la personificazione
della Vittoria e dei suoi simboli, i simboli della concordia e della solidarietà
(le mani che si stringono con il Signum), corone e ghirlande.
Continui sono i riferimenti al teatro e alle sue rappresentazioni, al
mondo del grottesco e del deforme, ai temi letterari, ai soggetti storici.
Frequenti sono i ritratti di scrittori, attori, musici, in scene spesso
anche molto complesse. Talvolta si hanno riproduzioni di opere figurative
famose, sculture o pitture.
Molto frequenti sono le rappresentazioni di animali, soprattutto se con
una qualche carica simbolica, come le aquile, i pavoni, le colombe, i
corvi, i cinghiali, i coccodrilli, le belve in genere (soprattutto quelle
viste nell'arena).
Amatissime erano le raffigurazioni riferibili alle attività del circo
e dell'arena, con scene di gare, ludi gladiatori, con combattimenti o
con oggetti simbolici (come gli elmi o le armi in genere).
Comuni appaiono le scene erotiche, proposte in termini assolutamente disinibiti.
Assente appare la sfera funeraria, anche se la lucerna era costantemente
usata come simbolo della luce che guida il morto nelle tenebre, collocata
nella sua mano al momento del seppellimento, o accanto alle sue ceneri,
come simbolo di rinascita. La lucerna propone quindi messaggi di vita,
in una dimensione gioiosa e spesso anche trasgressiva.
Talvolta era il corpo stesso della lucerna che assumeva una forma, mantenendo
la funzione con il beccuccio per lo stoppino. Si hanno così le lucerne
cosiddette singulares, a forma di animale, di nave, di pigna, di
nano itifallico, di fallo, di testa di toro (come in un esemplare a Biassono),
di elmo gladiatorio, ecc.
Fate click, sull'immagine, per visualizzare l'immagine completa della
lucerna
|




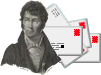 Museo
Civico "Carlo Verri"
Museo
Civico "Carlo Verri"
