Il Vino
(a San Martino ogni uva è vino)
1 2 3 4 5 6 7

| Museo Civico "Carlo Verri" Biassono Il Vino (a San Martino ogni uva è vino) 1 2 3 4 5 6 7 |
 |
L’effetto del vino veniva attribuito alla presenza del divino: bere insieme era un privilegio degli uomini liberi. Col vino giungevano anche i recipienti di bronzo usati presso gli Etruschi per versarlo, brocche eleganti con la bocca obliqua. I guerrieri più importanti portavano queste brocche nella tomba insieme al corredo funerario che doveva servire nell’aldilà. La casta dominante degli uomini che portavano la spada doveva mantenere il privilegio di bere il vino e di inebriarsi anche nel regno dei morti. Con la seconda guerra punica e la sconfitta (196 a.C.) anche della "coalizione brianzola", formata dagli Insubri (Celti padani) e dai Comensi (Liguri celtizzati), giunse nei nostri territori, divisi in staterelli poi federati con Roma, anche l’arte di coltivare la vite, forse insieme con immigrati dal centro Italia. I vitigni dovevano essere quelli dei colli vicino a Roma, gli stessi che troviamo nelle terre del Nord, dove ancora oggi il vino viene prodotto e consumato: la Valle del Reno, lo Champagne, l’Ungheria (da dove viene il Tokaj). Mentre nel Nord si usava comunemente per la conservazione e il trasporto del vino la botte in legno, da noi venne creato un recipiente con una forma particolare: il vaso a trottola. Si tratta di un vaso in terracotta con un collo molto stretto, adatto a venire tappato e sigillato (con cera o pece), e con un largo corpo panciuto lenticolare. Un antenato del fiasco.
Quando le popolazioni locali si romanizzarono, passando dalla lingua celtica a quella latina, nell’epoca dell’imperatore Augusto (31 a.C. - 14 d.C.), anche la forma del vaso da vino cambiò: dal vaso a trottola si passò ad una forma greco-italica, con un vaso dalla bocca stretta ed alta, il corpo panciuto e con un manico verticale. La Valle padana divenne una della aree europee più attive nella produzione del vino, anche nei terreni di pianura, come sui dossi sabbiosi della Lomellina. Il consumo doveva essere soprattutto locale, con una qualità certo non elevata, se non nelle zone dove ancor oggi lo si produce (le valli prealpine, l’Oltrepo, il Monferrato, le colline di Miradolo, ecc.). Per tutto il medioevo e per gran parte dell’età moderna la vite coprì vastissime aree, con una produzione sempre abbondante: anche nelle razioni riservate ai poveri dalla chiesa era previsto, accanto al pane, anche il vino. L’età moderna portò ad una crisi generalizzata della coltivazione della vite, che iniziò a non essere più economica in molte zone. Mentre diveniva sempre più frequente l’importazione del vino dell’Italia centromeridionale (specie dopo l’Unità: 1860-1861) le coltivazioni vennero trasformate. Dove prima veniva coltivata la vite ora il terreno veniva spianato e si seminava il riso (in pianura) o veniva abbandonato (in montagna). Quando la Filossera (un insetto che giunse dal nord-america) distrusse, nella seconda metà dell’800, la quasi totalità dei vitigni in Europa, gran parte dei terreni coltivati a vite vennero destinati ad altre colture. Solo in poche zone, come abbiamo detto, la produzione continuò e continua tuttora, ad altissimo livello qualitativo. Nelle nostra zona le coltivazioni sono quasi scomparse: rimangono pochi vigneti, come sulla collina di Montevecchia. Sono spariti i vigneti che nel passato erano in tutti i nostri comuni, Biassono compreso. |
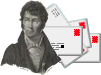 Museo
Civico "Carlo Verri" Museo
Civico "Carlo Verri"via san Martino, 1 20046 - Biassono (MI) tel./FAX 0392201077 cel. 3343422482 e-mail info@museobiassono.it. |
 |